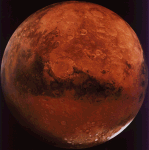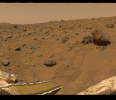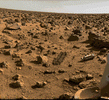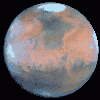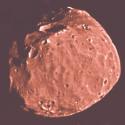Introduzione
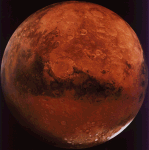
Marte: Il nome di Marte deriva da quello del notissimo dio della guerra della mitologia classica e l’accostamento è dovuto principalmente al colore rosso con cui risulta visibile in cielo. Dalle analisi fornite dalle sonde risulta che questo pianeta è il più simile alla Terra e l’unico su cui sia realizzabile in tempi non lunghissimi lo sbarco dell’uomo. Marte è visibile a occhio nudo e, osservato nel corso di un intero anno, mostra un apparente cambiamento di direzione.
Storia delle osservazioni
Storia delle osservazioni: Già gli antichi si erano accorti che il cammino di Marte in cielo nel corso dell’anno non è regolare. Grazie all’enorme mole di dati ottenuti dalle osservazioni di Tycho Brahe, Keplero riuscì a interpretare correttamente il moto di Marte, che possiede un’orbita fortemente ellittica nel suo viaggio intorno al Sole. Data la notevole eccentricità dell’orbita la distanza del pianeta dal Sole muta notevolmente, passando da un minimo di 206 a un massimo di 249 milioni di km; questo provoca inoltre una variazione sensibile nella distanza tra la Terra e Marte (da 57 a quasi 100 milioni di km) e una corrispondente variazione della luminosità di Marte così come ci appare dalla Terra. La durata della rotazione del pianeta fu determinata con una certa precisione da Gian Domenico Cassini (1625-1712) che nel 1666 la stimò in 24 ore e 40 minuti, molto vicina al valore reale, che è di 24 ore, 37 minuti, 22 secondi. L’astronomo Giovanni Schiaparelli (1835-1910), che fu direttore dell’osservatorio di Brera negli ultimi decenni del secolo scorso, compì una serie di importanti osservazioni del pianeta, prima con un telescopio equatoriale da 22 cm e poi con un rifrattore Metz da 50 cm. A partire dal 1875 tracciò infatti alcune mappe che "mostravano" mari e terre, ma soprattutto ipotizzavano l’esistenza di canali sulla superficie di Marte. Questi canali furono interpretati inizialmente come vie d’acqua strette e irregolari, poi come strutture rettilinee artificiali navigabili. Questi risultati ebbero una diffusione enorme in tutto il mondo, suscitando un dibattito internazionale sull’idea che i canali fossero più o meno artificiali e che quindi su Marte potesse esistere una civiltà avanzata. Le polemiche cominciarono a smorzarsi con gli studi di un altro astronomo italiano, Vincenzo Cerulli, che dimostrò che i canali in realtà erano solo il risultato di un’elaborazione mentale di strutture al limite della visibilità, un’illusione ottica dettata dall’inconscio! Nel 1907 anche Schiaparelli, con vero spirito scientifico, ammise il suo errore e confermò l’ipotesi di Cerulli, spegnendo così definitivamente ogni polemica.
Sonde su Marte

Sonde su Marte: Solo l’esplorazione diretta con le sonde ha permesso di entrare in possesso di dati più precisi e quindi di risolvere molti problemi che fino ad allora erano rimasti irrisolti. Ciò ha portato, come primo punto, a escludere la presenza su Marte della vita. Molto importante è stato l’atterraggio delle due sonde americane Viking sul suolo del pianeta rosso, che hanno ampliato le nostre conoscenze specialmente per quanto concerne la geomorfologia di Marte. Alla costruzione delle Viking si giunse attraverso un lavoro di progettazione e sperimentazione di navicelle, durato circa un decennio. La prima sonda giunta in prossimità del pianeta rosso è stata l’americana Mariner 4 che, nel Luglio del 1965, inviò 22 fotografie scattate mentre sorvolava la superficie a circa 10.000 km di altezza; queste immagini dimostrano che, almeno a livello macroscopico, non esiste vita su Marte. Nel 1969 Mariner 6, dotata per la prima volta di un computer riprogrammabile da terra, scattò 75 fotografie da 3429 km di altezza che mostrano la calotta polare sud con margini irregolari. La superficie è sovrastata da nubi di anidride carbonica, che costituisce probabilmente l’elemento principale dell’atmosfera marziana. Anche l’URSS negli stessi anni inviò una serie di sonde che con alterna fortuna raccolsero una notevole mole di dati, tra tutte ricordiamo Mars 2 (1971) e la serie Mars 4-5-6 (1973-74). Furono però gli Americani a scoprire, con Mariner 9, la montagna più alta di tutto il Sistema Solare, il monte Olympus, che arriva a 27 km sopra il suolo di Marte. La partenza delle Viking fu costellata di problemi: per difficoltà tecniche alla vigilia del lancio si dovette invertire l’ordine di decollo e il nome delle sonde venne quindi scambiato. Nonostante queste premesse la missione si rivelò un vero successo e le due sonde atterrarono a distanza di poco più di un mese l’una dall’altra in due zone diverse del pianeta nell’Agosto e nel Settembre 1976; vennero scelte appositamente due destinazioni distanti più di 6000 km per esplorare regioni differenti. Le due Viking erano dotate di un braccio telescopico mobile in grado di raccogliere campioni dal suolo e di portarli poi a bordo, dove venivano analizzati dal laboratorio in dotazione alle navicelle. La gestione di tutte le funzioni di bordo era controllata direttamente dal computer che, per la prima volta, era capace di decisioni sequenziali autonome. Su ognuno dei due moduli d’atterraggio, oltre al laboratorio biochimico, erano presenti anche strumentazioni meteorologiche, una telecamera digitale, che poteva riprendere immagini anche nell’infrarosso, e un sismografo. Le due sonde erano state progettate per trasmettere dati per tre mesi, ma durarono entrambe molto di più: Viking 2 si spense nel 1980, mentre Viking 1 cessò di funzionare nel 1982.
Superficie di Marte
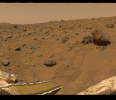
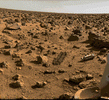
Superficie di Marte: La superficie di Marte assomiglia a quella della nostra Luna, anche se la sua morfologia è molto più complessa per la presenza di crateri, di pianure, di canyon e di vulcani. Su Marte è presente l’acqua (soprattutto nelle regioni polari), che però è intrappolata negli strati superficiali delle rocce sotto forma di permafrost. L’inclinazione dell’asse di rotazione determina anche per Marte l’alternanza delle stagioni e una variazione delle temperature sulla superficie. In media la temperatura è di -40 °C con punte di 14 °C in estate e di -120 °C in inverno. Le formazioni geologiche marziane non sono dovute, come quelle terrestri, alla tettonica a zolle, perché su questo pianeta la crosta non è divisa in zolle come la nostra. Il raffreddamento del pianeta e il conseguente aumento dello spessore crostale si opponevano infatti a uno sviluppo di tipo tettonico. Marte si è evoluto come un pianeta a una sola zolla e le sue caratteristiche sono sia endogene (risalita di materiale lavico dal mantello e vulcanesimo), sia esogene, come l’impatto di meteoriti che talvolta hanno fuso la crosta. Esiste una differenza tra i due emisferi: quello nord presenta pianure lisce e poco craterizzate, mentre in quello sud sono visibili crateri in misura 5 volte maggiore rispetto all’altra metà di Marte. Questo significa che l’emisfero meridionale è quello più antico e risale a circa 3,8 miliardi di anni fa, epoca del grande bombardamento meteoritico in tutto il Sistema Solare. Tra i due emisferi esiste una fascia con morfologia particolare, la regione di Tharsis, dominata dai grandi edifici vulcanici allineati dei monti Arsia, Pavonis, Ascreus, monte Olympus e da un sistema di canyon chiamato Valles Marineris.
Letti dei fiumi
Letti dei fiumi: Sulla superficie di Marte sono presenti molte strutture a forma di canale che ricordano i letti dei fiumi sulla Terra; questi letti sono giganteschi, alcuni di essi possono infatti raggiungere una larghezza di 200 km. Si possono distinguere due tipi di "canali": uno che si divide in corsi minori e tortuosi con moltissime ramificazioni di tipo fluviale, l’altro, più profondo, mantiene le stesse dimensioni per tutta la lunghezza e viene chiamato outflow. Questa differenza potrebbe essere dovuta a una diversa origine: il primo potrebbe essersi formato da un fiume tradizionale con acqua in superficie e presenza di clima mite per un tempo relativamente lungo; l’altro, creato da un flusso violento e improvviso di acqua creata per esempio dalla fusione degli strati di permafrost. Un esempio del secondo tipo è quello delle Valles Marineris, che sono lunghe più di 5000 km e che mostrano erosioni spiegabili solo attraverso l’impatto di enormi masse d’acqua liberatesi improvvisamente.
Oceani
Oceani: Nonostante il suo clima attuale sia freddo e secco, Marte mostra abbondanti evidenze dell’azione erosiva di acqua e ghiaccio. Letti fluviali imponenti, pianure periglaciali, permafrost e calotte ghiacciate stanno a dimostrare che nel corso della sua storia geologica il clima è stato temperato, permettendo la presenza di acqua in superficie. Le prime ere geologiche videro un intenso bombardamento meteoritico e un vulcanismo diffuso. Durante questo periodo si svilupparono i letti dei fiumi dall’erosione degli antichi crateri da parte dell’acqua. Il flusso necessario per queste erosioni non può essere spiegato solo con la fusione e lo scioglimento dell’acqua nello strato di permafrost, deve esserci stato per forza un ciclo idrodinamico con circolazione atmosferica di vapore acqueo. La presenza di letti fluviali equamente distribuiti sul pianeta fa pensare a un clima mite e regolato. Conseguenza quasi obbligata è l’esistenza di oceani stabili con ciclo completo dell’acqua: evaporazione del mare, condensazione in nubi e precipitazioni sul suolo marziano. Per spiegare la fine del ciclo idrodinamico e il relativo assorbimento dell’acqua da parte delle rocce porose in uno stato di permafrost, bisogna considerare l’instabilità dell’atmosfera. La massa minore del pianeta e, quindi, una gravità inferiore a quella terrestre sono la causa principale del mancato equilibrio; la maggior parte dei gas che componevano l’atmosfera di Marte è quindi sfuggita nello spazio fino ai valori attuali. Dopo una prima era con clima stabile prolungato si sono probabilmente avuti episodi isolati e ripetuti di formazione di un oceano in superficie. Questo spiegherebbe i canali di tipo outflow, l’esistenza delle Valles Marineris e di tutte le altre fratture che si estendono a partire dai monti Tharsis. La formazione degli oceani più recenti potrebbe essere dovuta essenzialmente alla fusione di permafrost provocata dal vulcanismo, una teoria, questa, confermata dalla posizione dei canyon, che sono sempre nei pressi di strutture vulcaniche. La liberazione di acqua genera cambiamenti nell’atmosfera che si riempie di vapore acqueo e di anidride carbonica liberata dal suolo. Per questo l’effetto serra aumenta considerevolmente, provocando un aumento della temperatura che causa, a sua volta, inondazioni delle calotte polari. Un tale ciclo finisce per l’infiltrazione lenta e costante dell’acqua nel terreno, che su Marte è quasi ovunque molto poroso. Contraendosi l’oceano, si riducono anche i suoi effetti sull’atmosfera, favorendo l’aumento dell’albedo (causa del ghiaccio che si forma in superficie) e quindi una diminuzione della temperatura. Quando un ciclo finisce, tutta l’acqua torna a essere imprigionata nel suolo marziano. Poiché la temperatura interna del pianeta è diminuita con il passare del tempo, anche l’attività vulcanica si è ridotta, il clima si è stabilizzato sugli attuali valori e difficilmente si ripeterà un altro ciclo oceanico.
L’atmosfera
L’atmosfera: Le analisi delle sonde hanno rivelato che la sottile atmosfera di Marte è composta attualmente per il 97% da anidride carbonica, per il 2,7% di azoto e per l’1,6% da argon; l’ossigeno rappresenta solo lo 0,13% e il vapore acqueo lo 0,03%. La pressione al suolo è molto bassa, circa 6 millesimi di quella terrestre; questa minore quantità di gas determina l’arrivo al suolo di una percentuale maggiore di radiazioni solari dannose che non riescono a essere assorbite. Il cielo di Marte non è azzurro come quello terrestre, ma nemmeno nero come sui pianeti senza atmosfera: un ipotetico astronauta che si trovasse sulla sua superficie vedrebbe un cielo rossastro per la presenza costante di polveri in sospensione. La bassa densità fa sì che la diffusione di calore attraverso i venti sia molto scarsa generando forti differenze di temperatura tra diverse aree. Le nubi marziane sono formate da acqua e anidride carbonica e assomigliano ai cirri terrestri; assumono invece un aspetto ciclonico vicino ai rilievi che, con la loro altezza, modificano le condizioni meteorologiche circostanti.
I poli di Marte
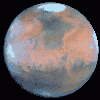
I poli di Marte: I poli sono una delle poche caratteristiche del pianeta visibili da Terra con un piccolo telescopio. Queste aree sono ricoperte da calotte di ghiaccio d’acqua su cui d’inverno si sovrappone uno strato di ghiaccio secco, cioè di anidride carbonica allo stato solido. Durante la stagione fredda le due calotte polari tendono a espandersi, raggiungendo rispettivamente 60° di latitudine N e 60° S. A queste latitudini lo strato di anidride arriva a 50 cm. Attorno alle calotte ghiacciate si estendono regioni in cui sono presenti depositi stratificati di polvere mista a ghiaccio; questi sedimenti sono particolarmente visibili sui fianchi delle fenditure e dei canyon. Con l’arrivo del caldo l’anidride carbonica sublima migrando verso il polo opposto. Può accadere talvolta che la sublimazione avvenga troppo velocemente; in questo modo vengono immesse nell’atmosfera enormi quantità di gas che generano venti violentissimi. Questi fenomeni sono accompagnati dall’insorgere di tempeste di polvere su scala planetaria capaci di rendere opaca l’atmosfera anche per qualche settimana prima che le polveri in sospensione tornino a depositarsi sul suolo.
I satelliti di Marte

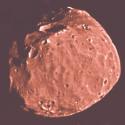
I satelliti di Marte: Marte possiede due piccoli satelliti, Phobos e Deimos, che prendono il nome dai due scudieri del Marte mitologico, dio della guerra. Scoperti relativamente tardi, nel 1877, hanno una forma irregolare e sono molto simili ad un asteroide, con diametri medi rispettivamente di 22 km e 14 km. Le orbite delle due lune sono inclinate di circa 2° rispetto al piano dell’equatore marziano e sono molto piccole. Phobos, il più vicino, compie un’orbita completa in 7 ore 39 minuti, compiendo tre rivoluzioni nel corso di una giornata di Marte; Deimos invece impiega 30 ore 17 minuti per fare un giro completo.
Dati
- Massa: 6,41 x 1028 g
- Massa (Terra = 1): 0,11
- Raggio equatoriale: 3393 km
- Densità media: 3,95 g/cm3
- Densità (Terra = 1): 0,72
- Volume (Terra = 1): 0,150
- Periodo di rotazione: 24 h 37 min 22 sec
Piero D’Incecco