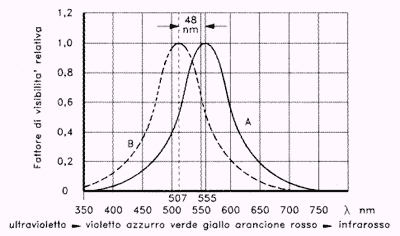La visione
Un corpo eccitato emette radiazioni elettromagnetiche e quindi energia; le radiazioni emesse con lunghezza d'onda λ compresa tra 380 nm e 780 nm producono sensazione visiva e rappresentano la cosiddetta energia visibile.
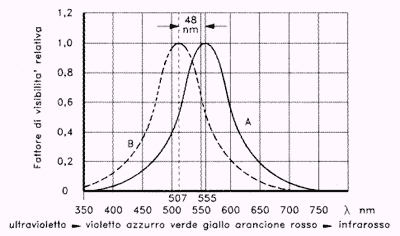
Ai valori di λ suddetti corrispondono rispettivamente il colore violetto cupo (380 nm) e rosso (780 nm). Nel campo intermedio si collocano le lunghezze d'onda corrispondenti alla percezione dei colori elementari, dalla cui miscela nasce tutta la gamma dei colori possibili.
Figura 1: Fattore di visibilità k in funzione di λ (A - visione diurna; B - visione notturna).
L'occhio percepisce meglio i colori intermedi; così, ad esempio, per ottenere la stessa impressione visiva, occorre convogliare sull'occhio molta più energia nell'unità di tempo con luce violetta o rossa, che con luce gialla.
Il massimo della sensazione visiva diurna, si ha per una radiazione monocromatica avente λ=555 nm (colore giallo-verdastro). Quando l'intensità della radiazione diventa particolarmente debole, il massimo della sensibilità si ha, invece, per una lunghezza d'onda λ=507 nm (colore azzurro-verdastro: la visione in questo caso è detta notturna o scotopica, in alternativa a quella diurna o fotopica) - Ecco perché, le guide ottiche impiegate per motivi di sicurezza negli ospedali ed aeroporti sono realizzate con lampade di tale colore.
La sensibilità visiva, al variare di λ, è espressa mediante il fattore di visibilità k(λ).
Grandezze fotometriche
Le grandezze fotometriche hanno lo scopo di fornire una valutazione oggettiva della "sensazione di luminosità". Le principali tra di esse sono:
a) il flusso luminoso e l'intensità luminosa (caratteristiche delle sorgenti)
b) l'illuminamento (rappresentativo dell'effetto prodotto dalle sorgenti su una generica superficie)
c) la radianza e la luminanza (rappresentative sia delle sorgenti che dei corpi illuminati, considerati a loro volta quali sorgenti secondarie).
Il flusso luminoso (Φ)
Il flusso luminoso misura l'intensità della sensazione luminosa; per radiazioni monocromatiche si ha:
Φv = k(λ) × P(λ)
in cui P(λ) è la potenza raggiante relativa alla lunghezza d'onda λ; k(λ) è il fattore di visibilità relativo alla stessa lunghezza d'onda λ.
Per radiazioni policromatiche il flusso luminoso è la somma dei flussi luminosi relativi alle singole lunghezze d'onda.
L'unità di misura del flusso luminoso è il lumen (lm).
L'intensità luminosa (I)
L'intensità luminosa esprime il flusso luminoso emesso da una sorgente puntiforme nell'angolo solido elementare dω attorno ad una data direzione r:
I = dΦ/dω
(dω è l'angolo solido al vertice del cono e dΦ è il flusso luminoso nella direzione r).
L'unità di misura dell'intensità luminosa è la candela (cd).
La candela è definita come l'intensità luminosa emessa in una data direzione da una sorgente che emette con lunghezza d'onda λ=555 nm e con intensità energetica in quella direzione di 1/683 W/sterad (essendo lo sterad l'unità di misura dell'angolo solido).
L'intensità luminosa di una sorgente nelle diverse direzioni consente di costruire il solido fotometrico che è la superficie delimitata dagli estremi dei segmenti aventi origine nella sorgente e rappresentativi dell'intensità luminosa in ciascuna direzione.
Viceversa, se di una sorgente artificiale è noto il solido fotometrico si può risalire al valore dell'intensità luminosa nelle varie direzioni.
L'illuminamento (E)
L'illuminamento in un dato punto di una superficie, è definito come il rapporto tra il flusso incidente sulla superficie elementare nell'intorno del punto considerato e la superficie elementare stessa:
E = dΦ/dA
L'unità di misura dell'illuminamento è il lux (lx), pari all'illuminamento di una superficie di 1 m² ricevente un flusso luminoso di 1 lumen uniformemente ripartito.
Valori tipici di illuminamento che si riscontrano in Natura sono i seguenti: 0.01 lux in una notte senza luna; 20.000 lux in una giornata con cielo coperto; 100.000 lux in una giornata estiva di sole.
La radianza (M)
La radianza M di un punto di una superficie è il rapporto tra il flusso luminoso emesso da un elemento di superficie attorno a quel punto e l'area dell'elemento stesso:
M = dΦ/dA
L'unità di misura della radianza è il lux su bianco (lux s.b.) pari a 1 lm/m².
Questa unità di misura nasce dal fatto che la radianza può essere espressa come M = ρ × E (essendo ρ il coefficiente di riflessione della superficie ed E l'illuminamento) e se ρ=1 (superficie perfettamente riflettente: bianca) si ha M=E.
La luminanza (L)
La luminanza in un dato punto di una superficie ed in una determinata direzione è definita come il rapporto tra l'intensità luminosa (emessa in quella direzione) e la superficie emittente proiettata su un piano perpendicolare alla direzione stessa:
L = dI/dAn
L'unità di misura della luminanza è il nit (1 nit = 1 candela/m²).
Spesso si utilizza ancora lo stilb (cd/cm²).
A titolo d'esempio, si ha:
- per lampade ad incandescenza chiare: L = 2 ÷ 7 × 10² cd/cm²
- per lampade ad incandescenza smerigliate: L = 5 ÷ 50 cd/cm²
- per lampade fluorescenti: L = 0.5 ÷ 2 cd/cm²
La differenza tra il valore della luminanza riferito ad un oggetto e la luminanza media del campo visivo esterno si chiama fattore di contrasto c.