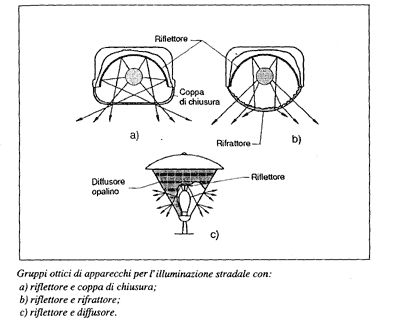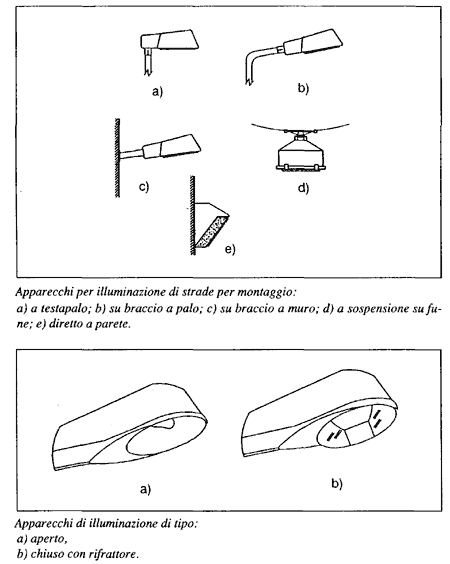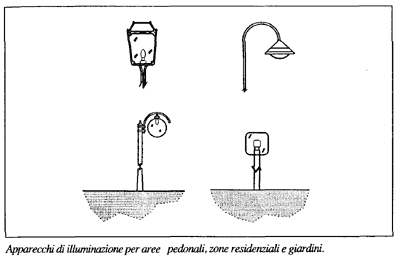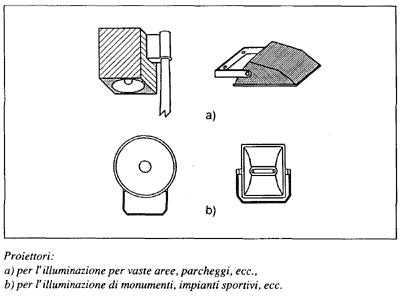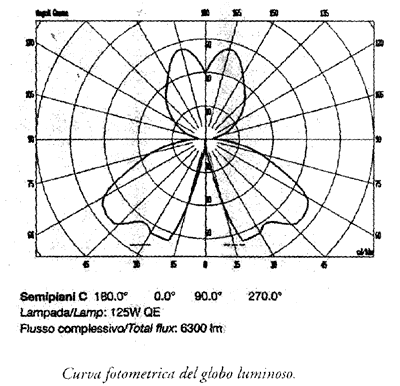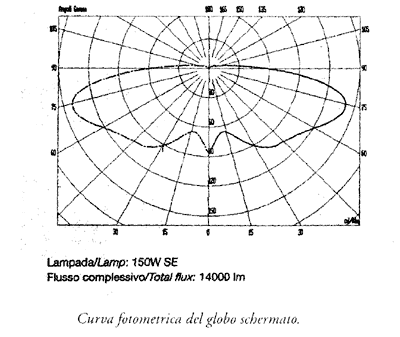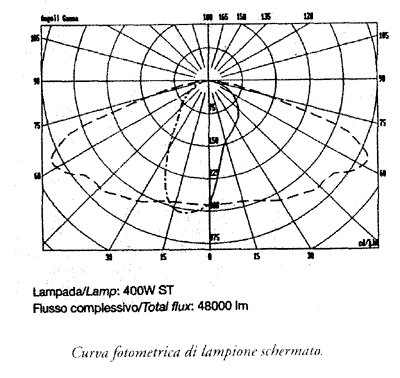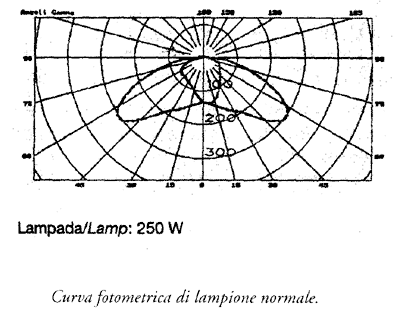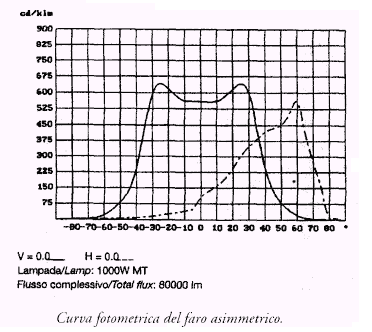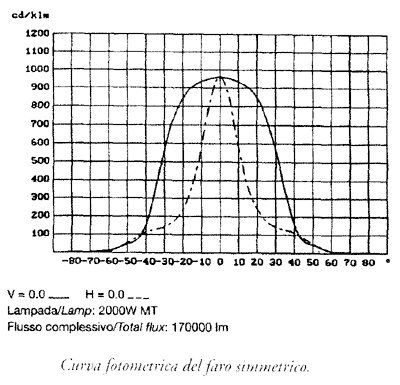Lampade
Classificazione e caratteristiche
Le lampade attualmente in commercio appartengono a 2 grandi famiglie, distinte dal diverso principio fisico su cui si basa la produzione di radiazioni luminose:
- ad incandescenza;
- a scarica di gas.
Nelle lampade ad incandescenza il filamento metallico presente è portato ad altissima temperatura (2000 ÷ 3000 °C) per effetto Joule e questo determina l’emissione di energia luminosa.
Nelle lampade a scarica di gas l’emissione di luce è prodotta dall’eccitazione degli atomi di uno o più gas presenti all’interno di un tubo.
In pratica, le lampade ad incandescenza emettono per temperatura (la luce è parte della trasformazione di energia elettrica in calore), le lampade a scarica di gas emettono per luminescenza (la luce è l’effetto della conversione diretta di energia elettrica in energia luminosa).
Parametri caratteristici di una lampada sono:
- Flusso luminoso: esprime la quantità di luce erogata per unità di tempo. È espresso in lumen.
- Efficienza luminosa (o efficienza specifica): è una misura della resa energetica della lampada; in pratica misura il costo della trasformazione della potenza elettrica in potenza luminosa. È espressa in lumen/watt.
- Tempo di accensione e di riaccensione
- Durata di vita: è un termine utilizzato per quantificare la durata di una lampada. Si può fare riferimento a:
- Vita media: è il numero di ore di funzionamento dopo il quale il 50% di un certo lotto di lampade (se sottoposte a prova) cessa di funzionare.
- Vita economica: è il numero di ore dopo il quale il livello di illuminamento è diminuito del 30%.
- Curva di decadimento: è la rappresentazione grafica dell’andamento del flusso di emissione, espresso in % del flusso iniziale, al variare delle ore di funzionamento.
- Resa cromatica: è l’attitudine di una sorgente luminosa a rendere i colori degli oggetti illuminati senza alterazioni; si esprime con un numero, variabile da 0 a 100, detto indice di resa cromatica Ra.
- Temperatura di colore: è la temperatura in Kelvin a cui occorre portare il corpo nero affinché emetta una luce uguale a quella emessa dalla sorgente in esame.
Lampade ad incandescenza
Le lampade ad incandescenza possono essere:
- normali;
- alogene.
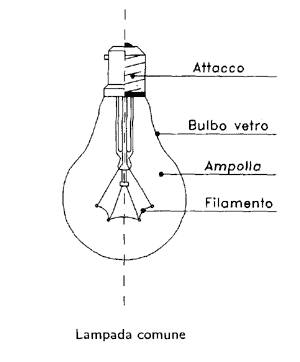
Le lampade ad incandescenza normali sono in disuso negli impianti di illuminazione esterna a causa della durata di vita limitata, della scarsa efficienza luminosa e della notevole sensibilità alle variazioni di tensione.
Le lampade alogene trovano impiego, principalmente, nell’illuminazione di monumenti nei centri storici.
Pregi delle lampade ad incandescenza:
- accensione istantanea
- tonalità di luce calda
- andata a regime immediata
Difetti delle lampade ad incandescenza:
- scarsa efficienza luminosa (max 20 ÷ 25 lm/w)
- estrema delicatezza
- ridotta durata di vita (max 2000 ore)
Lampade a scarica di gas
Le lampade a scarica di gas sono costituite da un contenitore, generalmente di vetro o di quarzo, nel quale si trova un aeriforme (vapori di mercurio o di sodio, gas rari, ecc.) ad opportuna pressione e 2 elettrodi che collegati ad una sorgente di tensione continua fanno sì che si inneschi e prosegua il fenomeno fisico responsabile della produzione della luce (che consiste essenzialmente nel movimento degli elettroni liberi presenti nella massa di gas all’interno del contenitore e conseguente ionizzazione di atomi di gas con produzione quindi di energia luminosa).
La tensione necessaria ad avviare il fenomeno è detta tensione d’accensione (o di innesco); la tensione necessaria per il mantenimento, più bassa di quella d’innesco, è detta tensione d’arco (o tensione di regime).
Le lampade a scarica di gas possono essere a bassa pressione (b.p.) o ad alta pressione (a.p.).
Gli aeriformi utilizzati di base per la scarica delle moderne lampade sono vapori metallici ed in particolare di sodio e mercurio.
- Lampade al sodio a bassa pressione
Hanno la più elevata efficienza luminosa (fino a 200 lm/w). Hanno l’inconveniente di emettere una luce monocromatica di colore arancione (589 ÷ 589.6 nm).
Queste sorgenti si utilizzano nei casi in cui la resa cromatica è meno importante ed è più importante l’acuità visiva - infatti, per bassi valori di illuminamento, la pupilla è costretta ad allargarsi molto ed in presenza di luce policromatica si hanno disturbi nella visione distinta; nel caso di luce monocromatica, i disturbi sono assai ridotti e sulla retina si forma un’immagine più definita nei contorni.
Per questo motivo tali lampade sono impiegate nell’illuminazione di strade e gallerie.
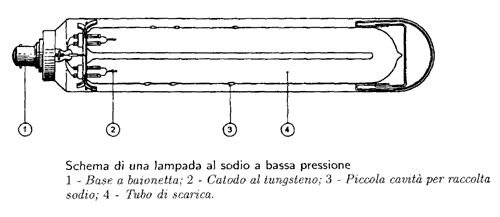
Pregi delle lampade al sodio a bassa pressione:
- elevata efficienza luminosa (200 lm/w)
- lunga durata
- maggior penetrazione del flusso luminoso nella nebbia
Difetti delle lampade al sodio a bassa pressione:
- andata a regime 12 ÷ 15 min
- dimensioni notevoli
- posizioni di funzionamento limitate (solo prossime all’orizzontale)
- costo elevato
- Lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione
Le lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione, dette anche fluorescenti, hanno elevati valori di indici di resa cromatica (fino a Ra=85 ÷ 95).
Emettono su tutto lo spettro visibile (400 ÷ 650 nm: dal violetto all’arancione).
Hanno vita media di circa 10.000 ore.
L’efficienza luminosa può arrivare a 90 lm/w.
L’esecuzione più comune è quella costituita da un tubo rettilineo o piegato ad U o a cerchio.
Sono ora nate anche lampade fluorescenti di piccole dimensioni, concorrenti delle lampade ad incandescenza. Rispetto a queste, hanno efficienza più elevata (50 ÷ 85 lm/W) e vita media più lunga (6000 ore).
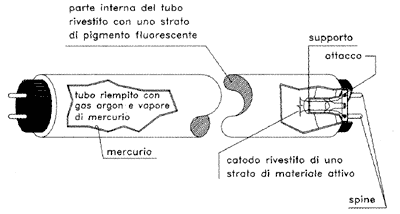
Pregi delle lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione:
- buona efficienza luminosa
- piccole dimensioni
- elevata affidabilità
- lunga durata
- funzionamento in qualsiasi posizione
- costo contenuto
Difetti delle lampade ai vapori di mercurio a bassa pressione:
- andata a regime 4 ÷ 5 min
- sovracorrente all’atto dell’accensione
- difficoltà di smaltimento (il mercurio è un rifiuto speciale)
- Lampade al sodio ad alta pressione
Nate per contrastare il problema del basso valore dell’indice di resa cromatica Ra tipico delle lampade al sodio a bassa pressione. L’uso ancora del sodio come aeriforme è dettato dall’esigenza di avere elevati valori di efficienza luminosa (superiore a quella delle lampade al mercurio o agli alogenuri).
Sono molto impiegate nell’illuminazione di strade urbane, centri storici, monumenti, piazze ed anche interni industriali.
Sono prodotte in forma tubolare o anche di ampolla, con potenze che possono variare da 70 a 1000 w.
Emettono con lunghezze d’onda comprese tra 550 e 750 nm. La volontà di ottenere una luce qualitativamente simile a quelle delle normali lampade ad incandescenza ha portato ad utilizzare lampade con sodio a pressioni sempre maggiori (fino a 95 kpa) con corrispondente indice di resa cromatica Ra=80, con conseguente diminuzione, però, dell’efficienza luminosa (43 lm/w).
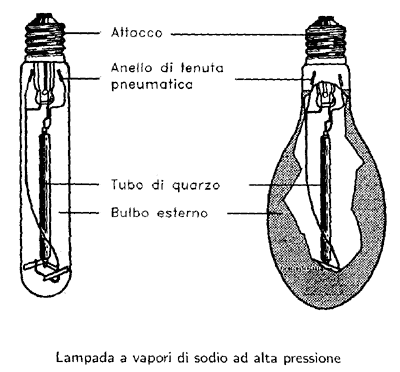
La loro vita media è 5000 ore.
Pregi delle lampade al sodio ad alta pressione:
- elevata efficienza luminosa
- lunga durata
- accettabile resa dei colori
- ridotte dimensioni
- funzionamento in qualsiasi posizione
Difetti delle lampade al sodio ad alta pressione:
- durata ridotta dalle variazioni di tensione
- andata a regime 5 ÷ 6 min
- sovracorrente all’atto dell’accensione
- costo elevato rispetto alle lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente
- Lampade ai vapori di mercurio ad alta pressione
Sono caratterizzate da bassa efficienza luminosa (35 ÷ 50 lm/w) e da basso indice di resa cromatica.
Per tali motivi sono scarsamente utilizzate.
- Lampade agli alogenuri
Contengono al loro interno oltre a vapori di mercurio anche alogenuri di sodio, di tallio, di iodio.
Rispetto alle lampade a vapori di mercurio hanno una resa cromatica ancora maggiore e sono quindi oggi in grado di coprire lo stesso campo di utilizzazione delle lampade fluorescenti convenzionali e delle lampade incandescenti ad alogeni.
Le versioni esistenti in commercio hanno un’ampolla tubolare chiara o fluorescente.
Per l’elevata resa del colore sono utilizzate soprattutto nell’illuminazione di campi sportivi, aree commerciali, monumenti, grandi superfici dove la resa dei colori è importante.
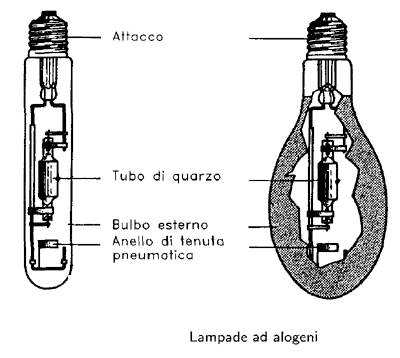
Ultimamente, tuttavia, sono state anche prodotte piccole lampade ad alogenuri aventi potenze ridotte (70 w con flussi di 5000 lm, mentre prima la potenza minima era 250 w), paragonabili a lampade incandescenti ad alogeni di 300 w, perciò, con notevole risparmio energetico.
Pregi delle lampade agli alogenuri:
- ottima resa cromatica
- elevata efficienza luminosa
Difetti delle lampade agli alogenuri:
- durata ridotta (circa la metà) rispetto a quelle ai vapori di mercurio
- posizioni di funzionamento limitate (solo prossime all’orizzonte)
- costo elevato
- tempo di riaccensione a caldo elevato (10 ÷ 15 min)
- Lampade ad induzione (o elettroniche)
Presentate dalla Philips nel 1990 saranno probabilmente le lampade del futuro.
Sono basate, ancora, sulla scarica di gas, però, la ionizzazione avviene senza la presenza di elettrodi ma grazie ad un circuito alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza (2.65 MHz).
Al loro interno è contenuta una miscela di mercurio e gas raro.
Hanno periodi di funzionamento dell’ordine di 60.000 ore.
Pregi delle lampade ad induzione:
- accensione rapida
- possibilità di regolazione del flusso luminoso
- eliminazione del fenomeno di “sfarfallamento” della luce
- eliminazione di qualsiasi disturbo e eventuale indipendenza dalla rete di distribuzione
- durata elevatissima (10 volte circa le altre lampade)
Difetti delle lampade ad induzione:
- costo elevato
- efficienza luminosa non elevata (64 lm/w)
Conclusioni
La qualità della luce emessa (indice di resa cromatica) è massima per le lampade agli alogenuri (luce bianchissima), diminuisce man mano per le lampade al mercurio b.p. (luce bianca), lampade al sodio a.p. (rosa-arancione), lampade al sodio b.p. (arancione).
Di contro, l’efficienza luminosa più elevata si ha per le lampade al sodio b.p.: può essere anche tripla rispetto a quella delle lampade al mercurio, più che doppia di quelle agli alogenuri ed una volta e mezza rispetto a quelle al sodio a.p. (questo vuol dire, ovviamente, a parità di flusso luminoso emesso, un dispendio energetico pari ad 1/3, alla metà e così via).
Le lampade al sodio, inoltre, a differenza di quelle al mercurio, con l’invecchiamento riducono di poco l’efficienza luminosa.
Per quanto riguarda la durata di vita quelle al sodio b.p. e quelle ai vapori di mercurio sono comparabili; leggermente più bassa per quelle al sodio a.p.; circa la metà per quelle agli alogenuri.
Quelle ad induzione, invece, hanno durata 6 ÷ 7 volte maggiore di quelle al sodio b.p. o al mercurio.
Per quanto riguarda il costo d’acquisto, le più economiche sono quelle al mercurio, seguite da quelle al sodio b.p. e al sodio a.p..
Tuttavia, il minor costo delle lampade al mercurio è, poi, compensato dai costi aggiuntivi di raccolta, trasporto e smaltimento a discarica controllata (trattandosi di un rifiuto speciale).
Maggiori, invece, i costi che riguardano le lampade agli alogenuri e decisamente maggiori quelli delle lampade ad induzione.